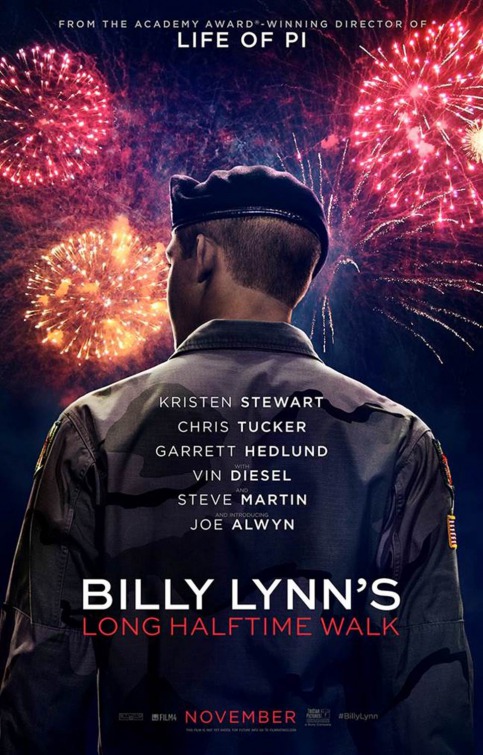Alle spalle la Notte degli Oscar ed il mancato post di commento alla stessa - quest'anno, devo dire, è andata di gran lusso grazie a Parasite -, torna il Bulletin nella sua formula tradizionale e legato almeno in parte ai titoli che hanno preso parte alla cerimonia più nota dell'anno cinematografico. Accanto a loro il Saloon ritrova un trio di vecchi amici che si erano perduti e prosegue nel recupero di una serie divenuta ormai un cult, paradossalmente, per i più piccoli di casa Ford.
MrFord
1917 (Sam Mendes, USA/UK/India/Spagna/Canada, 2019, 119')
Il grande favorito - ed il grande deluso - degli Oscar 2020, è giunto sugli schermi del Saloon qualche giorno prima della Notte, rafforzando l'impressione - fortunatamente sbagliata - che si sarebbe giocato l'incetta delle statuette con Joker, considerata l'abilità di entrambe le pellicole di risultare ad un tempo autoriali e profondamente pop.
Sam Mendes, che non è proprio l'ultimo arrivato, gira con grande tecnica una storia bellica che pare shakerare Dunkirk e Salvate il soldato Ryan, formalmente ineccepibile, arricchita da un paio di twist molto interessanti ma, a conti fatti, priva del cuore che ci si aspetterebbe da un titolo di questo genere.
Si lascia guardare, alimenta molto bene la tensione, rende molto bene le potenzialità dei mezzi tecnici che il Cinema oggi offre, eppure manca la scintilla che rende un buon film qualcosa di davvero memorabile, o che, nonostante sia stato ispirato dai racconti del nonno del regista, reduce della Seconda Guerra Mondiale, il regista avesse davvero la necessità di raccontare.
ODIO L'ESTATE (Massimo Venier, Italia, 2020, 110')
Ricordo benissimo gli esordi televisivi di Aldo, Giovanni e Giacomo, così come la loro esplosione ai tempi di Mai dire gol e de I corti in teatro. Divenuti campioni d'incassi con il loro primo film Tre uomini e una gamba, ebbero il grande merito di far riscoprire una comicità all'italiana leggera e mai volgare, che fino a Chiedimi se sono felice - a mio parere il loro lavoro migliore - ed in parte a Tu la conosci Claudia? riuscirono a mantenere a livelli interessanti.
Poi, come spesso accade per i comici consolidati, finirono vittime di loro stessi attraversando un decennio totalmente da dimenticare sia in televisione che al Cinema, finendo per allontanarsi da quello che era stato lo spirito del loro inizio: fortunatamente, ricongiuntisi con il vecchio amico Massimo Venier, i tre paiono aver ritrovato proprio quello spirito in Odio l'estate, dai tempi del già citato Chiedimi se sono felice di gran lunga la loro produzione migliore.
Forse parzialmente telefonato, ma genuino e piacevole, questo nuovo film porta con sé la malinconia che, a fine estate, rapisce da bambini così come da adulti, con la sensazione che la stagione delle vacanze e degli amori effimeri sia ad un tempo il momento più bello e più terribile dell'anno, perchè così come in grado di regalare magie, spietatamente giunge al termine sempre troppo presto.
Un pò come la vita. Ed è bello che Aldo, Giovanni e Giacomo non solo se ne siano ricordati, ma siano riusciti a raccontarlo quasi al loro meglio.
SCRUBS - STAGIONE 6 (ABC, USA, 2007)
Prosegue il recupero dell'intera cavalcata di Scrubs, ai tempi seguita saltuariamente dal vecchio cowboy e divenuta a scoppio ritardato uno dei cult del Saloon soprattutto grazie alla presa avuta sui Fordini ed alla presenza di un idolo totale come il dottor Cox.
Al sesto giro di giostra i medici del Sacro Cuore mostrano i primi segnali di stanca tipici delle produzioni lunghe, ed un mordente che non pare più quello degli esordi nonostante i numerosi avvenimenti importanti della stagione - il consolidamento del matrimonio di Turk e Carla, il secondo nato in casa Cox, il matrimonio di Elliot, il figlio di J.D. -: Scrubs è sempre piacevolissimo da vedere e per accompagnare i sempre più incasinati pasti di Casa Ford è perfetto, eppure in cuor mio spero, con la settima stagione, di poter assistere ad un colpo di coda che mi permetta di affrontare le ultime tre annate al meglio, e non con l'impressione che avrebbero dovuto chiudere prima.
JOJO RABBIT (Taika Waititi, Nuova Zelanda/Repubblica Ceca/USA, 2019, 108')
L'appuntamento con Jojo Rabbit, uno dei titoli più recensiti anche qui nella blogosfera nel periodo precedente la Notte degli Oscar, è stato tra i più assurdi della mia vita recente di spettatore: tra lavoro, palestra, ritmi incalzanti e circo dei Fordini, nell'ultimo anno ho diminuito molto la mia percentuale di film visti alla sera, ma mai come nel giorno di Jojo Rabbit ho avuto un tracollo clamoroso.
Dei venti minuti scarsi visti a pezzi a fronte dei quasi centodieci complessivi, devo ammettere che il lavoro di Taika Waikiki mi è parso interessante ed emotivamente pronto a colpire - al contrario, ad esempio, di 1917 -, un pò come se avessero mescolato Wes Anderson ad una commediaccia tamarra ma dal cuore d'oro.
Sospendo il parere sul voto, e mi riprometto un recupero in tempi non sospetti, magari nel weekend, decisamente più lontano dal rischio crollo che ormai è un must della settimana lavorativa.
![Bloody Sky (Flames Series Vol. 2) di [Ferrari, Bianca]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/417QoSZu-HL.jpg)

![Burning Sand (Flames Series Vol. 1) di [Ferrari, Bianca]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZmU95Bv3L.jpg)