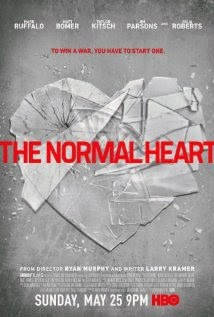Probabilmente non esiste un mistero più grande di quello che offriamo noi stessi.
Che si parli di corpo, o mente.
In fondo, gli abissi che nasconde il nostro cervello sono sconosciuti alla scienza almeno quanto i miracoli che è in grado, in positivo o in negativo, di compiere il corpo.
Per non parlare del concetto più ampio di Natura.
Forse, un giorno, saremo addirittura in grado di decidere del destino delle nostre strutture fisiche, o capiremo come l'energia che ci muove si evolve e saremo in grado, in barba alle religioni, di guadagnare davvero un'esistenza eterna.
Ma al momento, tutto è affidato a quello che proprio la Natura sceglie per noi, dai cambiamenti climatici, ai cataclismi, al modo di evolversi ed invecchiare della "carne".
Personalmente, anche se ormai molto vicino ai quaranta, mi sento più consapevole, forte e prestante di quanto fossi quando ne avevo venti: ho una tenuta da sportivo, ho prestazioni fisiche migliori, bevo molto di più, conosco i miei limiti e cerco un passo alla volta di superarli, vedo più chiaramente tante cose che allora potevo solo immaginare.
Eppure, la mia è una condizione transitoria, passeggera, mutevole.
Alla fine dello scorso gennaio, quando mio padre ha iniziato la sua lotta contro il cancro - pur se, fino ad ora, con successo e rispetto ad una situazione gestita per tempo, fortunatamente -, ho ripensato a quanto indistruttibile, in barba a tutti gli incidenti in bicicletta collezionati nel corso della vita, mi fosse sempre sembrato, e a quanto, inevitabilmente, la Natura ci impone, senza appello: Alex Garland, forte di una materia di base decisamente interessante, mette sul piatto una delle grandi piaghe della medicina, della scienza e in un certo senso della filosofia cercando di analizzarla dall'interno, quasi fosse un ostacolo con il quale fare i conti non tanto arrendendosi, o combattendo coltello tra i denti, quanto cercando di comprendere memori dell'insegnamento dell'Eraclito del Panta rei, quasi la malattia, il decadimento, il cambiamento facessero talmente parte del nostro universo e della nostra essenza da potersi considerare parte di noi.
In effetti, a ben guardare, l'invecchiamento stesso potrebbe essere considerato alla stessa stregua: iniziamo la nostra vita con un sovraccarico di energie, le vediamo esplodere, impariamo a fatica a gestirle e proprio nel momento migliore ne perdiamo progressivamente il controllo, fino a spegnerci.
Parrebbe quasi un'ingiustizia, se non fosse parte di un disegno che ancora non siamo riusciti ad osservare nel suo complesso, distaccati.
Lo stesso disegno che cercano di comprendere, ognuna grazie alla propria esperienza e sensibilità, le protagoniste della spedizione di questa storia che non sarà tra le più originali portate sullo schermo ma che, derivativa oppure no, conferma il talento di uno sceneggiatore e regista da tenere indubbiamente d'occhio, in grado di ribaltare uno dei concetti più oscuri e spaventosi che l'epoca moderna ha finito per dover affrontare e cercare di comprendere e proporlo al pubblico come una sfida, un'idea nuova, un cambiamento terribile quanto necessario per affrontare, chissà, un futuro differente da quello che ci siamo o potremmo mai immaginarci.
In fondo, in barba a battaglie, studi, storie d'amore, legami destinati a finire ed altri ad iniziare, violenza e conflitti, progetti ed idee, scenari ipnotici che ricordano Kubrick o Malick e cast di stelle emergenti o affermate, uomini o donne, passato o futuro, la questione primaria è legata al fatto che, per quanto mi riguarda, sarei disposto a cambiare, ad evolvere, a cercare, a scoprire pur di vivere in eterno: che si tratti di fiori, di sangue, di grida d'aiuto o di forme spaventose come sculture deformi.
Ma per quanto possa aggrapparmi a qualcosa, non è detto che la Natura sia d'accordo.
O che una luce negli occhi non possa cambiare tutto quello che avevo creduto, pensato e voluto.
Del resto, per citare Rocky, "la Natura è più furba di quello che l'Uomo crede".
Anche quando l'Uomo è parecchio avanti.
MrFord